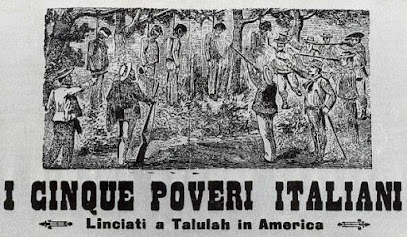Nelle note a margine della conferenza “Los caminos de Dante. Firenze y el exilio” del passato venerdì 28 maggio, tenutasi nel sito della Biblioteca Nacional de Costa Rica (è possibile rivederla su https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr) spiccano alcuni appunti che non è stato possibile elaborare per il tempo a disposizione. In particolare, come l’impegno politico costi a Dante l’esilio. Dante nasce, cresce, si fa uomo a Firenze, una città che gli calza come un’armatura: rampollo di una famiglia benestante, esponente di riguardo del dolce stil novo, autore di “La vita nuova” e voce rispettata al centro del dibattito sull’uso o no del volgare.
La politica, però, ieri come oggi è una brutta bestia. Dante ci si impegna e ci si impegola, facendosi coinvolgere nel partito dei guelfi bianchi, sviluppando una testarda e idealista campagna morale contro i mali del suo tempo. Appoggia l’autonomia comunale contro ogni tipo di ingerenza esterna e chiede a se stesso e agli altri una virtù che pochi conoscono: l’onestà. Firenze sta crescendo e appare a chi la visita un fenomeno urbano e sociale in piena espansione. Dante ne denuncia invece la fragilità interna, dovuta ai difetti dell’animo umano, che si lascia sopraffare dalla smania del potere. Punta il dito contro i potenti della sua epoca, addirittura contro il papa soldato Bonifacio VIII che, spada in mano, tuona per espandere il potere temporale della Chiesa. Ritenuto da Dante responsabile della corruzione ecclesiastica, Bonifacio è però avversario temibile. Cosa ci guadagna il poeta da questa sua campagna? Una condanna a morte, l’esilio vita natural durante, l’ignominia del suo nome sbeffeggiato come traditore, la vergogna e il sequestro dei beni. La sua vendetta ha un titolo ed è la “Divina Commedia” dove entrano tutti, ma proprio tutti, i suoi accusatori. Ed è così che il corpo letterario dell’opera, si trasforma in un trattato morale contro la degenerazione dei costumi, il malaffare, l’avidità provocata dal potere, il peccato in generale che va oltre l’accezione del termine nell’ambito di etica cristiana, ed è una macchia indelebile in chi non sa essere uomo tra gli uomini.
Profondamente religioso, Dante diventa così il primo vero intellettuale laico della storia occidentale. Dalla sua cattedra itinerante, ci dice che non dobbiamo abituarci alla deriva della società, ma che abbiamo l’obbligo morale di reagire. Ci insegna a non essere ignavi (ricordate i versi dedicati a papa Celestino? “vidi e conobbi l’ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto”), ma di prenderci le nostre responsabilità. Non c’è condanna a morte o esilio che tenga, o saremmo destinati per l’eternità a inseguire l’insegna bianca priva di significato, disdegnati sia dalla beatitudine che dagli inferi.